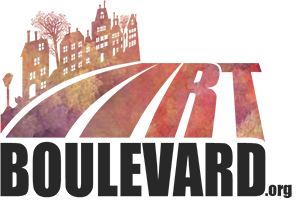Javascript must be enabled to continue!
Siphons in Roman Aqueducts
View through CrossRef
I SIFONI NEGLI ACQUEDOTTI ROMANIIl principio dei sifoni rovesciati era ben conosciuto a Roma e dal II secolo a.C. erano di uso corrente sia negli impianti idraulici domestici che nei grandi acquedotti del paese. Vengono studiati i resti archeologici dei sifoni tipici, in particolare quelli intorno a Lione, e un'analisi dell'idraulica del loro funzionamento identifica tre sollecitazioni a cui erano sottoposti: pressione statica, frizione e inerzia (= velocitá dell'acqua in movimento). Nonostante la ‘vis spiritus’ di Vitruvio, la pressione dell'aria non rappresentava una difficoltá perchè i sifoni ne erano privi. Esisteva la pressione dell'acqua e, per la legge di fisica idraulica, questa non poteva essere regolata da valvole limitatrici di pressione, ventose o altri dispositivi simili; poteva soltanto essere contenuta, e i ‘colliviaria’ di Vitruvio sono identificati come rubinetti di drenaggio usati anche per la depurazione. Tuttavia, le tubazioni romane erano completamente in grado di resistere alle altissime pressioni prodotte sul fondo dei grandi sifoni e, al contrario di quanto comunemente si crede, la pressione non rappresentava un vero problema nel rifornimento idrico romano, nè i romani tentavano di evitarlo in modo particolare. Ció é dimostrato dalle grandi dimensioni dei sifoni di cui é conosciuto il buon funzionamento — Beaunant, lungo km. 2½ e profondo m. 123, era piú alto di due Ponts du Gard, uno sull'altro, e le sue tubazioni resistevano a una pressione di 12 atmosfere. Se i sifoni non furono usati piú largamente, la cause é probabilmente economica e non tecnica, dato che i ponti in muratura erano meno costosi del trasporto del piombo per le tubazioni.
Title: Siphons in Roman Aqueducts
Description:
I SIFONI NEGLI ACQUEDOTTI ROMANIIl principio dei sifoni rovesciati era ben conosciuto a Roma e dal II secolo a.
C.
erano di uso corrente sia negli impianti idraulici domestici che nei grandi acquedotti del paese.
Vengono studiati i resti archeologici dei sifoni tipici, in particolare quelli intorno a Lione, e un'analisi dell'idraulica del loro funzionamento identifica tre sollecitazioni a cui erano sottoposti: pressione statica, frizione e inerzia (= velocitá dell'acqua in movimento).
Nonostante la ‘vis spiritus’ di Vitruvio, la pressione dell'aria non rappresentava una difficoltá perchè i sifoni ne erano privi.
Esisteva la pressione dell'acqua e, per la legge di fisica idraulica, questa non poteva essere regolata da valvole limitatrici di pressione, ventose o altri dispositivi simili; poteva soltanto essere contenuta, e i ‘colliviaria’ di Vitruvio sono identificati come rubinetti di drenaggio usati anche per la depurazione.
Tuttavia, le tubazioni romane erano completamente in grado di resistere alle altissime pressioni prodotte sul fondo dei grandi sifoni e, al contrario di quanto comunemente si crede, la pressione non rappresentava un vero problema nel rifornimento idrico romano, nè i romani tentavano di evitarlo in modo particolare.
Ció é dimostrato dalle grandi dimensioni dei sifoni di cui é conosciuto il buon funzionamento — Beaunant, lungo km.
2½ e profondo m.
123, era piú alto di due Ponts du Gard, uno sull'altro, e le sue tubazioni resistevano a una pressione di 12 atmosfere.
Se i sifoni non furono usati piú largamente, la cause é probabilmente economica e non tecnica, dato che i ponti in muratura erano meno costosi del trasporto del piombo per le tubazioni.
Related Results
Hubungan Perilaku Pola Makan dengan Kejadian Anak Obesitas
Hubungan Perilaku Pola Makan dengan Kejadian Anak Obesitas
<p><em><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-langua...
Crescimento de feijoeiro sob influência de carvão vegetal e esterco bovino
Crescimento de feijoeiro sob influência de carvão vegetal e esterco bovino
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="pt-BR">É indiscutível a import...
A Wideband mm-Wave Printed Dipole Antenna for 5G Applications
A Wideband mm-Wave Printed Dipole Antenna for 5G Applications
<span lang="EN-MY">In this paper, a wideband millimeter-wave (mm-Wave) printed dipole antenna is proposed to be used for fifth generation (5G) communications. The single elem...
Κωδικολογία: νέες κατευθύνσεις και όρια
Κωδικολογία: νέες κατευθύνσεις και όρια
<p><span style="line-height: 150%; font-variant: small-caps; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: black; font-size: 11pt"><span style="line-height: 150%; f...
Topological Analysis of Metabolic Networks Based on Petri Net Theory
Topological Analysis of Metabolic Networks Based on Petri Net Theory
Petri net concepts provide additional tools for the modelling of metabolic networks. Here, the similarities between the counterparts in traditional biochemical modelling and Petri ...
Peyami Safa’s Novels at the Intersection From Modern to Modernist Fiction
Peyami Safa’s Novels at the Intersection From Modern to Modernist Fiction
Batı romanında 20. yüzyılın başlarında yeni roman anlayışı ve yeni anlatım teknikleriyle geleneksel/ gerçekçi romandan farklı romanlar yazıldığı görülmüştür. Özellikle James Joyce,...
The Chronological Development of Roman Provincial Coin Iconography
The Chronological Development of Roman Provincial Coin Iconography
AbstractThe Aims of this Chapter are to Provide a brief introduction to Roman provincial coinage as background to the book as a whole, and to outline the key developments in Roman ...
Longitudinal Thermal Movement of Polymer Concrete Irrigation Aqueducts
Longitudinal Thermal Movement of Polymer Concrete Irrigation Aqueducts
This study evaluates the longitudinal thermal movements of precast polymer concrete aqueducts made with MMA modified UP polymer concrete. The aqueduct investigated in this study ha...