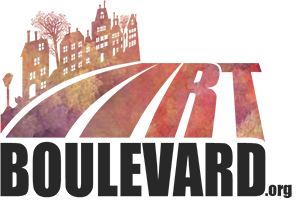Javascript must be enabled to continue!
Essere Cives Christiani sotto Traiano e Marco Aurelio: clandestini in patria?
View through CrossRef
La domanda nasce dall’idea di accostare in maniera provocatrice il termine clandestinus, nella sua valenza contemporanea negativa e dispregiativa, al civis romanus christianus nel II secolo: oggi come ieri il clandestino, secondo questa prospettiva, è un migrante accusato di tutti mali della società in cui vive (cfr. Tert. Ap. XL, 2) e che per questo resta in una zona d’ombra, oltre i confini della legge poiché non integrato nel sistema dei valori politici e giuridici in cui si trova arrivando a definirsi egli stesso come «un forestiero senza patria» (Ep. ad Diogn. V, 5).In un contributo strutturato in otto paragrafi, compresa un’introduzione e una conclusione, si ripercorre la storia dei primi due secoli del cristianesimo e, più specificatamente, da quando migra ideologicamente dalla sua culla, il giudaismo in Palestina, per diffondersi in tutto il principato romano arrivando così a uno scontro con le istituzioni.La prima parte si focalizza su alcuni passi neotestamentari poiché in essi vi è la chiave per comprendere questo distacco. In particolare, negli Atti degli Apostoli, emerge il ‘limite’ del giudaismo che, fondato su un’identità di nazione (λαός), non può aprirsi ai gentili come invece fa il cristianesimo. Si sviluppa da qui – e continua anche in alcuni autori cristiani del II secolo – un’aspra polemica: il cristianesimo, infatti, rivendica il suo essere l’unico e vero erede dell’ebraismo, quest’ultimo una sorta di puzzle più o meno uniforme delle utopie teocratiche delle élite sacerdotali e scribali di Gerusalemme formatosi a seguito della nascita del primo nucleo della diaspora (VI secolo a.C.).Dunque, il cristianesimo viene accolto anche da alcuni gentili dando inizio a uno scontro giuridico, politico e ideologico con le istituzioni romane. Si propone così, nella seconda parte, una nuova interpretazione dello scambio epistolare tra Traiano e Plinio il Giovane (Ep. X, 96 ed Ep. ad Plin. X, 97) effettuato fra il 109 e il 113 per scoprirne le sottigliezze argomentative che hanno dato vita al primo atto legislativo contro i cristiani. I suoi contenuti si rivelano molto preziosi poiché, grazie ad essi, si chiarificano le scelte delle istituzioni all’epoca di Marco Aurelio riportate in diversi documenti dell’epoca, tra cui spicca l’importantissimo Martyrium Lugdunensis di cui ad oggi si conservano lunghi estratti (ap. Eus., H.E. V. 1-2) che raccontano minuziosamente il massacro subito da un certo numero di cristiani a Lione, probabilmente nel 176.L’analisi giuridico-politica che si effettua di questo documento – per la prima volta in maniera dettagliata – delinea l’approccio legale delle istituzioni e conferma che la politica di Marco Aurelio ricalca quella di Traiano. Difatti, sia lui che il suo legatus della Gallia Lugdunensis non vogliono fare dei cristiani dei martiri a tutti i costi. Piuttosto, essi cercano di indurli ad abiurare per reintegrarli nel solco delle antiche tradizioni romane, il mos maiorum. Un obiettivo che assume un’importanza certamente maggiore se tra gli accusati ci sono dei cives, i rappresentanti, o ancora meglio i difensori, del mos maiorum e perciò costoro sono chiamati a rispettarlo in maniera particolare. Si spiega così la decisione del legato augusteo di punire in maniera esemplare l’«inflexibilis obstinatio» – come la chiamava Plinio (Ep. X, 96. 3) – di un civis particolarmente noto in città e renitente all’abiura. Il legato, infatti, oltrepassando i limiti del suo imperium sui cives sanciti dalla Lex Iulia de vi, condanna espressamente questo civis non alla decapitazione – come voleva la prassi ribadita da Marco Aurelio – ma a bruciare su una sedia di ferro.L’analisi del Martiyrium Lugdunensis mostra inoltre che – come stabilito da Traiano – solo a seguito di una delatio il cristiano poteva essere portato in giudizio e che dunque non andava ricercato d’ufficio. Nel caso di Lione, molto spesso quest’accusa formale veniva compiuta dai pagani in massa a causa della reputazione negativa che aleggiava sui cristiani ascrivibile ai presunti atti disumani da loro compiuti e che Plinio il Giovane definiva «flagitia cohaerentia nomini» (Ep. X, 96. 2). Questi provocavano nei loro confronti vessazioni di ogni tipo, atti d’intolleranza, violenza ed esclusione dai luoghi pubblici.In conclusione, che il civis christianus fosse davvero un clandestinus in patria si evince anche dalla sua prospettiva, un vero e proprio ossimoro per le istituzioni romane: l’abiura e il conseguente adempimento, anche solo pro forma, dei culti che mostrassero devozione verso il mos maiorum e verso il princeps erano considerati atti inconciliabili con la sua fede essendo il cristianesimo una religione esclusivista. Tuttavia, questo non impediva agli apologeti cristiani dell’epoca di affermare la loro fedeltà al princeps volendo, in fondo, sentirsi parte integrante del mondo romano.
Title: Essere Cives Christiani sotto Traiano e Marco Aurelio: clandestini in patria?
Description:
La domanda nasce dall’idea di accostare in maniera provocatrice il termine clandestinus, nella sua valenza contemporanea negativa e dispregiativa, al civis romanus christianus nel II secolo: oggi come ieri il clandestino, secondo questa prospettiva, è un migrante accusato di tutti mali della società in cui vive (cfr.
Tert.
Ap.
XL, 2) e che per questo resta in una zona d’ombra, oltre i confini della legge poiché non integrato nel sistema dei valori politici e giuridici in cui si trova arrivando a definirsi egli stesso come «un forestiero senza patria» (Ep.
ad Diogn.
V, 5).
In un contributo strutturato in otto paragrafi, compresa un’introduzione e una conclusione, si ripercorre la storia dei primi due secoli del cristianesimo e, più specificatamente, da quando migra ideologicamente dalla sua culla, il giudaismo in Palestina, per diffondersi in tutto il principato romano arrivando così a uno scontro con le istituzioni.
La prima parte si focalizza su alcuni passi neotestamentari poiché in essi vi è la chiave per comprendere questo distacco.
In particolare, negli Atti degli Apostoli, emerge il ‘limite’ del giudaismo che, fondato su un’identità di nazione (λαός), non può aprirsi ai gentili come invece fa il cristianesimo.
Si sviluppa da qui – e continua anche in alcuni autori cristiani del II secolo – un’aspra polemica: il cristianesimo, infatti, rivendica il suo essere l’unico e vero erede dell’ebraismo, quest’ultimo una sorta di puzzle più o meno uniforme delle utopie teocratiche delle élite sacerdotali e scribali di Gerusalemme formatosi a seguito della nascita del primo nucleo della diaspora (VI secolo a.
C.
).
Dunque, il cristianesimo viene accolto anche da alcuni gentili dando inizio a uno scontro giuridico, politico e ideologico con le istituzioni romane.
Si propone così, nella seconda parte, una nuova interpretazione dello scambio epistolare tra Traiano e Plinio il Giovane (Ep.
X, 96 ed Ep.
ad Plin.
X, 97) effettuato fra il 109 e il 113 per scoprirne le sottigliezze argomentative che hanno dato vita al primo atto legislativo contro i cristiani.
I suoi contenuti si rivelano molto preziosi poiché, grazie ad essi, si chiarificano le scelte delle istituzioni all’epoca di Marco Aurelio riportate in diversi documenti dell’epoca, tra cui spicca l’importantissimo Martyrium Lugdunensis di cui ad oggi si conservano lunghi estratti (ap.
Eus.
, H.
E.
V.
1-2) che raccontano minuziosamente il massacro subito da un certo numero di cristiani a Lione, probabilmente nel 176.
L’analisi giuridico-politica che si effettua di questo documento – per la prima volta in maniera dettagliata – delinea l’approccio legale delle istituzioni e conferma che la politica di Marco Aurelio ricalca quella di Traiano.
Difatti, sia lui che il suo legatus della Gallia Lugdunensis non vogliono fare dei cristiani dei martiri a tutti i costi.
Piuttosto, essi cercano di indurli ad abiurare per reintegrarli nel solco delle antiche tradizioni romane, il mos maiorum.
Un obiettivo che assume un’importanza certamente maggiore se tra gli accusati ci sono dei cives, i rappresentanti, o ancora meglio i difensori, del mos maiorum e perciò costoro sono chiamati a rispettarlo in maniera particolare.
Si spiega così la decisione del legato augusteo di punire in maniera esemplare l’«inflexibilis obstinatio» – come la chiamava Plinio (Ep.
X, 96.
3) – di un civis particolarmente noto in città e renitente all’abiura.
Il legato, infatti, oltrepassando i limiti del suo imperium sui cives sanciti dalla Lex Iulia de vi, condanna espressamente questo civis non alla decapitazione – come voleva la prassi ribadita da Marco Aurelio – ma a bruciare su una sedia di ferro.
L’analisi del Martiyrium Lugdunensis mostra inoltre che – come stabilito da Traiano – solo a seguito di una delatio il cristiano poteva essere portato in giudizio e che dunque non andava ricercato d’ufficio.
Nel caso di Lione, molto spesso quest’accusa formale veniva compiuta dai pagani in massa a causa della reputazione negativa che aleggiava sui cristiani ascrivibile ai presunti atti disumani da loro compiuti e che Plinio il Giovane definiva «flagitia cohaerentia nomini» (Ep.
X, 96.
2).
Questi provocavano nei loro confronti vessazioni di ogni tipo, atti d’intolleranza, violenza ed esclusione dai luoghi pubblici.
In conclusione, che il civis christianus fosse davvero un clandestinus in patria si evince anche dalla sua prospettiva, un vero e proprio ossimoro per le istituzioni romane: l’abiura e il conseguente adempimento, anche solo pro forma, dei culti che mostrassero devozione verso il mos maiorum e verso il princeps erano considerati atti inconciliabili con la sua fede essendo il cristianesimo una religione esclusivista.
Tuttavia, questo non impediva agli apologeti cristiani dell’epoca di affermare la loro fedeltà al princeps volendo, in fondo, sentirsi parte integrante del mondo romano.
Related Results
¿Es Marco Aurelio un estoico aristoniano? Una revisión al supuesto acercamiento de Marco Aurelio a la axiología aristoniana
¿Es Marco Aurelio un estoico aristoniano? Una revisión al supuesto acercamiento de Marco Aurelio a la axiología aristoniana
En este trabajo sostengo que Marco Aurelio no se adhiere a la axiología heterodoxa del estoico Aristón de Quíos, sino que es fiel a la axiología estoica ortodoxa. Al rechazar esa a...
"Postumus" w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa
"Postumus" w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa
Dalle informazioni trasmesse da Gellio da un lato risulta che la legge delle dodici tavole considerava postumus un bambino nato al massimo nel decimo mese. Dall’altro, pero, egli r...
Analisa Sistem Informasi Suber Daya Manusia COBIT 4.1 Pada Perguruan tinggi(Studi Kasus STMIK Bina Patria)
Analisa Sistem Informasi Suber Daya Manusia COBIT 4.1 Pada Perguruan tinggi(Studi Kasus STMIK Bina Patria)
Abstrak-STMIK Bina Patria merupakan perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang Teknologi informatika dan komputer di magelang. Dalam upaya peningkatkan kinerja para pegawai,b...
Entrevista al Professor Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
Entrevista al Professor Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
En el marco de la celebración del 40 aniversario de la Sociedad Brasileña de Educación Comparada, la Revista Brasileña de Educación Comparada entrevista al Professor Dr. Marco Aure...
Los componentes literarios en el Barrio Santa Tere, de Marco Aurelio Larios.
Los componentes literarios en el Barrio Santa Tere, de Marco Aurelio Larios.
Marco Aurelio Larios, quien en vida fue profesor de la licenciatura en Letras hispánicas y la licenciatura en Escritura creativa de la UDG, se dedicó al estudio y aprendizaje de la...
La figura pedagógica de Marco Aurelio en la obra de Herodiano
La figura pedagógica de Marco Aurelio en la obra de Herodiano
En el presente artículo se realizará un análisis de la figura pedagógica del emperador Marco Aurelio en la Historia del Imperio Romano de Herodiano. El fin que perseguimos en este ...
La figura pedagógica de Marco Aurelio en la obra de Herodiano
La figura pedagógica de Marco Aurelio en la obra de Herodiano
En el presente artículo se realizará un análisis de la figura pedagógica del emperador Marco Aurelio en la Historia del Imperio Romano de Herodiano. El fin que perseguimos en este ...
emperador Marco Aurelio, ¿Perseguidor de los cristianos?
emperador Marco Aurelio, ¿Perseguidor de los cristianos?
Ninguno de los documentos antiguos que relacionan a este emperador con los cristianos (Vita Abercii, Tertuliano y la carta apócrifa de Marco Aurelio al senado sobre el episodio de ...